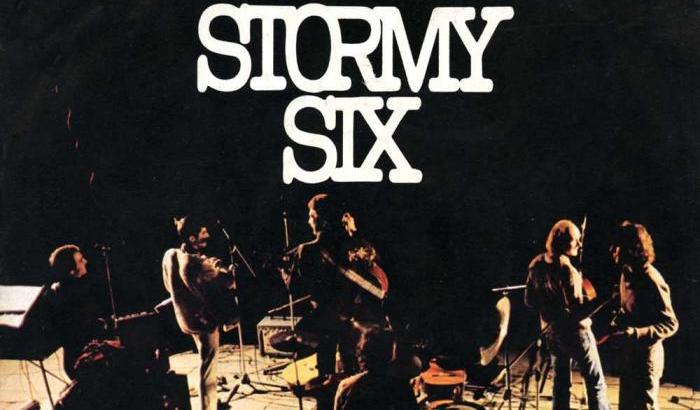Gli appassionati di progressive rock ricordano Franco Fabbri come vocalist, chitarrista, compositore del gruppo degli Stormy Six, attivo dal 1966 al 2012. Non tutti però sanno che Fabbri è anche un acuto musicologo antesignano negli studi della popular music, con alle spalle un’attività di docenza accademica e una multiforme esperienza di direzione artistica e gestionale. Ai seminali studi di musicologia al suo attivo, si aggiunge l’ultimo lavoro, Il tempo di una canzone. Saggi sulla popular music, pubblicato da Jaca Book (pp.360, € 22), una raccolta di saggi e interventi redatti nell’ultimo decennio, dedicati alla creazione di un ordine metodologico nel caotico panorama di un quarantennio di studi.
La materia è intrigante, poiché l’autore affronta il discorso dei generi e delle etichette, e temi complessi quali i rapporti tra culture dominanti e sottoculture, l’autonomia dell’opera musicale vs. il contesto in cui essa prende forma, l’industria che presiede ai gusti del pubblico, la creazione di valori e canoni, nello sforzo ermeneutico di definire la popular music “in un quadro teorico che permetta di considerare differenze e analogie tra diversi tipi di musica”. Di grande interesse i saggi sulle origini del folklore musicale a Napoli e negli USA, sulle culture del suono nel Dodecaneso, sul rock, sul beat, sulla canzone d’autore. Pagine significative sono dedicate al progressive rock italiano degli anni Sessanta e Settanta, con un profondo excursus storico sulle ascendenze musicali che presiedettero ai primi album degli Stormy Six.
Imperdibile il capitolo su una delle più originali esperienze di autogestione artistica e imprenditoriale portata avanti da musicisti e operatori musicali, quella della Cooperativa L’Orchestra (1975-1983). Seguono sezioni altrettanto avvincenti sul concetto di influenza musicale, sull’ascolto binaurale e sulle tecnologie audio, sul sound delle surf bands, di Peter Gabriel, di De André, nonché parti dedicate alle colonne sonore, al ruolo del silenzio e alla musica elettronica nel cinema di fantascienza. Il lavoro si chiude con un saggio che dà il titolo al volume, dove, con il consueto acume critico, si discetta sulla forma canzone e la sua relazione con il testo, con suggestive incursioni nelle “ballate narrative”, come la celebre “Percy’s Song” di Bob Dylan.
Per l’occasione abbiamo intervistato l’autore.
Lei è stato tra gli antesignani negli studi sulla popular music. A distanza di 40 anni dalla fondazione dell’International Association for the Study of Popular Music di cui lei fu tra i promotori e direttori, a che punto è in Italia la ricerca in questo ambito così ampio e di non semplice definizione?
Dopo alcune premesse negli anni Sessanta (il libro Le canzoni della cattiva coscienza e la prefazione a quel libro scritta da Umberto Eco, e più tardi un articolo sul rock firmato da Luciano Berio e pubblicato sulla “Nuova Rivista Musicale Italiana”), gli studi “seri” sulla popular music cominciano ad affermarsi in Italia proprio all’inizio degli anni Ottanta, anche grazie alla circostanza favorevole rappresentata dalla presenza all’Università di Bologna di Gino Stefani, Roberto Leydi, Mario Baroni. Nel 1983 la seconda conferenza internazionale della IASPM si svolge proprio in Italia, a Reggio Emilia. Un ruolo importante lo hanno giocato le riviste “Musica/Realtà” (diretta da Luigi Pestalozza) e “Laboratorio Musica” (diretta da Luigi Nono). A parte qualche tesi di laurea, però, la ricerca sulla popular music non riesce a radicarsi nell’università, sostanzialmente perché l’organizzazione degli studi musicali nell’università italiana si basa su due settori disciplinari – la musicologia tout court e l’etnomusicologia – che escludono per definizione la popular music dai propri obiettivi di studio. Quella situazione non è mai cambiata: le discipline musicologiche sono comunque minoritarie anche nell’ambito degli studi umanistici, e le pratiche nepotistiche notoriamente diffuse in tutta l’accademia italiana impediscono che si faccia spazio a una disciplina che, in termini ministeriali, “non esiste”, e potrebbe fare concorrenza a quelle esistenti rispetto ai posti da ricercatore e da docente, ai progetti di ricerca, eccetera. Intorno agli anni 2010 gli etnomusicologi hanno manifestato una certa apertura verso gli studiosi di popular music (una tendenza internazionale anche ora, man mano che l’etnomusicologia si apre alla popular music, se non altro per la progressiva scomparsa del suo oggetto di studi storico, la musica di tradizione orale). Ma nel momento in cui si è capito che “troppi” studiosi di popular music bussavano alle porte dell’accademia, le porte si sono chiuse immediatamente. Oggi i docenti o i ricercatori italiani incardinati nell’università italiana si contano sulle dita di una sola mano (e nemmeno tutti a tempo indeterminato). Nonostante questo, godono di notevole prestigio a livello internazionale.
Dunque, non si scorge nessun cambiamento all’orizzonte?
Qualsiasi cambiamento è reso impossibile dalla rigida organizzazione dei settori disciplinari. Questo atteggiamento, tra l’altro, è diffuso anche fuori dall’Italia (soprattutto in Francia e in Germania). È ovvio che un nuovo posto di ricercatore o associato specializzato in studi sulla popular music è un posto in meno per uno studioso di musicologia storica o di etnomusicologia, e nel sistema paternalistico (o nepotistico) dell’università italiana – casi recenti di concorsi pilotati lo dimostrano – appare impossibile che chi detiene il potere in quei settori compia un atto di generosità e approvi l’ingresso di “estranei”. Se posso citare un caso personale, nel 2013 vinsi l’abilitazione a professore di prima fascia (ordinario) in etnomusicologia, ma successivamente non mi arrivò nessuna chiamata, nemmeno dal dipartimento dove insegnavo. Sarei stato il terzo o quarto ordinario di etnomusicologia, in un settore piccolissimo, e avrei rappresentato una “testa di ponte” intollerabile (perché, fra l’altro, chi si opponeva a me immaginava che mi sarei comportato allo stesso modo, mandando avanti i miei “protetti”). Così sono rimasto ricercatore, e a 65 anni sono stato mandato in pensione.
Nel suo libro Il tempo di una canzone lei dedica particolare attenzione alla riflessione teorica sui generi musicali, un discorso perennemente dibattuto e che rivela una certa persistente confusione metodologica nell’ambito degli studi di musicologia. Si arriverà mai alla definizione di un linguaggio condiviso tra studiosi e critici musicali a vario titolo?
Direi che fra gli studiosi ormai ci sia una certa concordanza. Per molti anni sono stato l’unico a pubblicare saggi su quell’argomento, ma di recente sono usciti alcuni libri che riprendono quel dibattito, alcuni in accordo, altri in disaccordo con le mie posizioni, ma tutti accettandone le premesse e il linguaggio. Di studiosi fermi sulle posizioni crociane dell’inutilità dei generi ce ne sono ben pochi (e, perlopiù, la consistenza delle loro affermazioni è molto debole). Purtroppo non vale lo stesso per i critici musicali, che spesso sono più sensibili agli umori del mercato, e magari hanno poco tempo per aggiornarsi sull’avanzamento degli studi. Ad esempio, la recente uscita del Club Tenco a favore di una “canzone senza aggettivi”, e dell’affermazione che tutto sommato esista solo un confine fra la canzone “bella” e quella “brutta”, e che si debbano abbandonare gli “steccati”, è una tirata neocrociana, che serve solo a giustificare ideologicamente l’apertura ad autori che la comunità della canzone d’autore aveva a lungo tenuto a distanza.
In un saggio del suo libro lei rintraccia una sorta di “world music” ante litteram tra fine Ottocento e inizio Novecento, notando singolari similitudini tra la musica napoletana e quella greca, anche di origine anatolica, generi a loro volta influenzati da balli e canzoni dell’America Latina e rimescolati nelle esperienze dei café chantant europei e nordafricani. In ciò scorge anche un “presentimento inquietante, minaccioso”, un’anticipazione su scala minore di fenomeni come la globalizzazione, le migrazioni, gli scontri di civiltà che occupano il nostro presente. Può spiegare questo punto della sua riflessione?
Vediamo… Il punto di partenza di quella riflessione è la critica all’idea (dura a morire) che la popular music coincida sostanzialmente con il mainstream angloamericano dagli anni Cinquanta del Novecento in poi. Se si accetta, invece, che la musica che oggi convenzionalmente si chiama popular è quel “terzo tipo” di musica che si afferma a partire dai primi decenni dell’Ottocento, in seguito all’accettazione sociale dei concetti di “musica classica” e “musica folk” inventati (grosso modo) fra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, allora comprendiamo che il fado portoghese, la canzone napoletana, la chanson francese, il flamenco, il tango, le canzoni dei minstrel show, sono tutti aspetti della popular music, e precedono la nascita del jazz e l’affermazione dei generi che a metà del Novecento concorreranno alla nascita del rock’n’roll. La musica, grazie all’editoria (prima) e alla fonografia (poi) ha anticipato di molti decenni i processi di globalizzazione, sia dal punto di vista della produzione industriale che del consumo. E quanto alle migrazioni e agli scontri di civiltà, la popular music ne porta i segni fin dalle origini.
Il fatto di essere anche un musicista cambia la percezione e l’approccio alla sua attività di studio e di ricerca?
Indubbiamente. Ci sono delle cose che so e che vivo da quando, a sedici anni, ho cominciato a suonare, a cantare, a scrivere canzoni, e che costituiscono un’esperienza fondamentale per i miei studi. Quando leggo i testi di altri studiosi, percepisco rapidissimamente se sono persone che fanno musica, o se non l’hanno mai praticata.
Da un punto di vista intellettuale ed emotivo, avverte delle analogie tra l’ebbrezza di suonare davanti ad un pubblico entusiasta e il piacere di una lezione di musicologia rivolta a giovani studenti appassionati?
Posso dire che quando faccio lezione (ultimamente, purtroppo, online) l’esperienza che ho maturato suonando davanti a un pubblico mi sostiene. E quando qualche studente mi scrive che ha apprezzato le mie lezioni, sì, è come ricevere un grosso applauso. Anche se quest’ultima è un’emozione difficile da confrontare.
Nel suo libro lei analizza struttura e attività della Cooperativa l’Orchestra, un’avanguardistica forma di autogestione di musicisti e operatori musicali attiva dal 1975 al 1983 e di cui lei fu tra i fondatori. Cos’è rimasto di quella straordinaria esperienza?
Sono rimaste le persone (purtroppo, non tutte): ad esempio, Moni Ovadia, Umberto Fiori (poeta e critico, a lungo cantante e autore di testi degli Stormy Six), Alessandro Carrera (insegna a Houston, ritenuto uno dei più profondi conoscitori di Bob Dylan nel mondo), Mario Arcari (suonatore di ance con Fossati, De André e altri), Silvia Paggi (etnomusicologa a Nizza), oltre a Piero Milesi (il compianto co-produttore di Anime salve), e tanti altri. A volte qualcuno mi chiede: “Ma perché non rifondiamo l’Orchestra?” E c’è qualche giovane (come alcuni miei ex studenti, a Milano) che ci prova, anche se le condizioni politiche, economiche e culturali di oggi sono profondamente cambiate.
Generalmente oggi i fan e le riviste specializzate considerano gli Stormy Six un gruppo di progressive rock. La sua posizione su questa attribuzione è molto più sfumata. Dovesse indicare un’etichetta per il gruppo che l’ha vista protagonista, quale sarebbe la più corretta? O il discorso sui generi non può cogliere la portata di un lungo e composito percorso musicale?
Gli Stormy Six hanno navigato da un genere all’altro sia perché il loro rapporto col pubblico era in continuo mutamento (e il gruppo rispondeva a una sorta di domanda sociale su cosa si dovesse comporre e suonare), sia perché cambiavano le formazioni, sia perché cambiava la musica intorno, e le suggestioni e i modelli che ci si presentavano erano in continua evoluzione. Ma, soprattutto, mancava l’obbligo del marketing a mantenere un’identità costante e riconoscibile. Quale artista, dopo il successo di un album come Un biglietto del tram, avrebbe pubblicato un anno dopo un album di musica di scena largamente improvvisata, solo strumentale, con la partecipazione di jazzisti?
Secondo lei, nel mutato contesto odierno, sarebbe possibile per una giovane band seguire l’esempio performativo di ricerca musicale unita all’impegno politico e culturale che caratterizzò la storia degli Stormy Six?
Ne sono sicuro, anche se manca (direi) quella domanda sociale, che consisteva anche, per il pubblico, in un desiderio di essere continuamente sfidati.