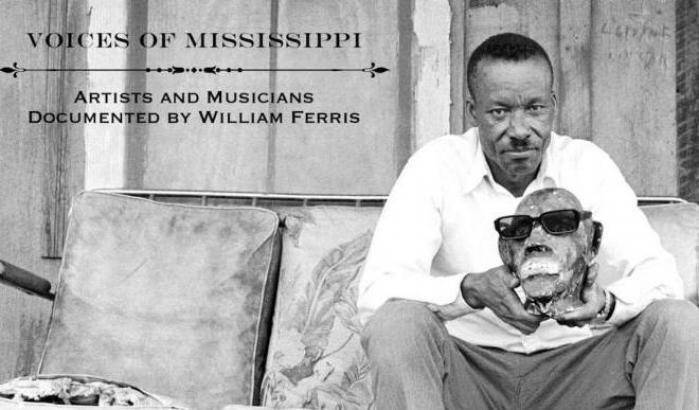di Rock Reynolds
“C’è un treno lento in arrivo, deve arrivare da tanto tempo e sta acquistando velocità.” È così che la voce di un Bob Dylan pimpante apre il 13° volume delle “Bootleg Series”, una genialata della sua casa discografica o, forse, dello stesso Dylan, a cui vendere tanti dischi non ha mai fatto particolarmente schifo. Ed è anche dalla riproposizione di versioni live di brani più o meno noti delle varie fasi della sua carriera che si riesce a ricomporre il puzzle impazzito di uno degli artisti più insondabili e inarrivabili degli ultimi cento anni. E quel treno è la tanto agognata salvezza, la conquista della serenità attraverso la fede, dopo anni travagliati in cui la pace familiare si era trasformata in un drammatico e dolorosissimo divorzio e in cui nemmeno la forza catartica del rock bastava più.
Il paracadute di Gesù. Ci voleva ben altro e Bob Dylan, spiazzando tutti, tirò fuori una serie di canzoni che, per un rampollo di una famiglia ebrea del Midwest come la sua, dovevano certamente rappresentare un bel salto nel vuoto. Ma il paracadute di Gesù, si sa, si può aprire per tutti, quando meno uno se lo aspetta. Quel paracadute significò per Bob Dylan incanalare la propria rabbia e la propria creatività in un solco chiaro, ma non per questo meno interessante. Il primo disco della trilogia (anche se, in realtà, Infidels, quarto capitolo, chiude il cerchio) è il sottovalutatissimo Slow train coming, qui ottimamente rappresentato. A differenza di molti dischi di Dylan del periodo, si nota abbondantemente la raffinatezza degli arrangiamenti, peraltro mai pomposi, e il preciso confezionamento, impreziosito dalla presenza di Mark Knopfler e Pick Withers degli allora popolarissimi Dire Straits. E, nelle versioni live presentate sia nella confezione doppia che in quella del cofanetto super-lusso di nove CD, quella canzoni acquistano ulteriore credibilità e grande vigore. Saved, la cui copertina mi risulta leggermente indigesta, è in realtà un grande disco gospel-rock e persino Shot of love, non un capolavoro, contiene qualche perla.
Eppure, proprio con l’uscita dell’LP Shot of love, Paul Nelson, un critico della rivista “Rolling Stone” ebbe a dire, schifato, “Per dire la verità, la mia reazione iniziale fu l’ennesimo esempio della vecchia e nota sindrome di Bob Dylan, ovvero, siccome i successi passati dell’artista hanno rappresentato tanto per molti di noi, tendiamo a concedere il beneficio del dubbio alla sua ultima opera. Non più. per quel che mi riguarda, [quella sindrome] si ferma qui”.
A caccia di suoni. D’accordo, il vecchio nostalgico dylaniano inorridirà, ma uno dei principali crucci di Dylan, una delle sue difficoltà della seconda, se non della prima ora, è stata proprio la ricerca di un suono, la capacità di dare un suono alle sue grandi idee. Ci sono dischi su dischi in cui la forza di certe canzoni galleggia pericolosamente in un’aurea mediocrità produttiva. Risentendoli oggi, alcuni dischi, soprattutto quelli della fase immediatamente successiva al periodo cristiano, sono orrendi. Una pericolosa stasi creativa, incupita da una crisi di valori personali e portata del tutto fuori strada da arrangiamenti imbarazzanti, persino in dischi sorretti dalla potenza sonora e dall’eleganza formale di una grande band come Tom Petty & The Heartbreakers.
Quali sono questi dischi? Dylan ne ha pubblicati talmente tanti che risulta difficile sceglierne qualcuno, ma titoli come Empire burlesque, Knocked out loaded, Down in the groove oggi risultano imbarazzanti. Qualcuno potrebbe insinuare una mia preclusione per la produzione di Dave Stewart degli Eurythmics, per esempio. Nulla di più sbagliato. Ho adorato certe cose da lui fatte insieme ad Annie Lennox così come mi sono piaciute alcune sue collaborazioni, in particolare proprio quella con Tom Petty. Ma, se per quello, non ho urlato al miracolo nemmeno quando Bob si è affidato alle cure del produttore Daniel Lanois. Oh mercy, da molti salutato come un capolavoro, non mi ha mai convinto. Slow train coming, invece, forse perché ha rappresentato il mio imprinting dylaniano, continuo a ritenerlo una delle sue cose migliori, se si eccettuano i quattro o cinque dischi degli anni Sessanta che lo hanno reso immortale.
Su e giù nella storia. Quanti si sono chiesti se Bob Dylan non si fosse per caso fumato le ultime cellule grigie funzionanti insieme a qualche droga acquistata da un pusher nuovo? Peccato che questa domanda se la siano fatti in molti, moltissimi – suvvia, non negherete anche voi, dylaniani impenitenti nonostante i ripetuti sberleffi del vate di Duluth, di essere rimasti volta per volta profondamente delusi dalla sua ultima prova incolore – in svariate occasioni nel corso della lunghissima carriera di questo straordinario e misterioso artista, come se sancirne di volta in volta la fallibilità fosse un sistema per rendercelo più vicino, più simpatico, più umano. Qualcuno pensava che, finito il folk revival, anche quel borioso ragazzotto del Minnesota sarebbe ripiombato nell’anonimato. Qualcun altro pronosticava che, dopo i fasti della svolta elettrica, quella sarebbe rimasta la vocazione universale del rocker Bob Dylan. Qualcuno altro ancora era convinto che, dopo la sbornia della fine degli anni Sessanta e il mal di testa dei primi anni Settanta, Dylan sarebbe tornato all’acustico. E che dire di chi sperava che l’avvento del punk lo avrebbe tolto di mezzo. Già, sembra quasi che gli improperi e gli slanci quasi blasfemi del punk, sottolineati da sputi e urla stonate, abbia spianato il terreno alla discussa conversione di Dylan. Altri ancora avrebbero seguitato a essere contro o non del tutto a favore, perché su Dylan chiunque si sente in dovere di dire qualcosa. Un po’ come i nostri politici. Si pensi alle sterili polemiche sul suo Nobel, cosa recente, ma che ormai, nel calcolo cosmico del personale calendario delle ere dylaniane, sembra appartenere a un Giurassico lontanissimo.
La conversione, si diceva. Ecco come ce l’ha spiegata Dylan stesso, facendo tutto sommato eco al “In hoc signo vinces” di costantiniana memoria. “Ho avvertito una presenza nella mia stanza che non sarebbe potuta essere altri che Gesù… Gesù ha posato una mano su di me. Una sensazione fisica.” E meno male che il leggendario produttore Jerry Wexler, di fronte a quelle che sembrerebbe siano state le ripetute insistenze di Dylan ad abbracciare la vera fede, avrebbe semplicemente risposto, “Bob, hai a che fare con un ebreo ateo di sessantadue anni. Sono senza speranza. Limitiamoci a realizzare un album”. Della serie, zitto e pedala!
Dylan, si sa, non è mai stato particolarmente bravo con le risposte. A lui, come a tutti i grandi, sono sempre piaciuti maggiormente i grandi interrogativi. Persino quando sconcerta i suoi fan della prima ora – i vecchi beatnik sinistrorsi e, in quanto tali, atei per definizione oppure gli edonisti figli dei fiori, più interessati al misticismo globale che a epifanie cristiane o, peggio ancora, i nipotini dei fiori, quelli che hanno preso la sberla più violenta della fine del sogno, tra anni Settanta e Ottanta – Dylan riesce sempre a inserire lo sberleffo persino nei sermoni più infuocati o nelle prediche di sapore più autenticamente messianico.
Un amico americano, un missionario evangelico che ha vissuto lungamente in Italia – già, chi avrebbe mai pensato che una oscura chiesa della Pennsylvania ritenesse utile inviare un giovane hippie cristiano nella cattolicissima Italia per fare proseliti? – qualche anno fa organizzò un festival di “Christian Music” proprio sul Lago di Garda, invitando band da ogni continente. Il titolo del festival? “Rock on the Rock Festival”, perché “it’s (NOT) only Rock’n’Roll”. E se quella Roccia fosse la stessa su cui Bob Dylan costruì almeno tre, forse quattro LP che, nella discografia di molti altri colleghi del tempo sarebbero forse stati accolti con grande favore e che, nel suo caso, furono spesso liquidati come fuffa, come banalità rock in salsa messianica? “Solid rock” è davvero rocciosa, un rock – e scusate l’ardita ripetizione – che pulsa come pochi brani del tempo riuscivano a pulsare. “In the garden” è semplicemente da brividi e fortuna che Dylan ogni tanto la pesca ancora dal cilindro quando si esibisce. “Gotta serve somebody” pare scritta ieri e potrebbe essere stata scritta domani. C’è un tangibile autocompiacimento persino nei brevi inviti a rispondere alla chiamata dall’alto, un cameratismo palpabile con i fantastici musicisti di una band compatta, capitanata dal bassista Tim Drummond – anche questa una costante della poetica live di Dylan – con un uso quasi scolastico della tecnica del “call and response”, in cui il predicatore invita i fedeli a sottolineare le sue frasi di adorazione ripetendole e mugugnando dei sì, accompagnando i mugugni con cenni di assenso.
Trouble no more. La verità è che Bob Dylan se ne frega abbondantemente di tutto e di tutti. Le note di copertina di Trouble no more sono illuminanti e dimostrano una volta di più che siamo in presenza di un gigante, di un artista vero, che sa che, per dare il meglio di sé, deve sentirsi completamente a suo agio nei propri panni. Badate bene, lui stesso a volte ne ha indossati alcuni che non gli calzavano a pennello. Ma osare è una delle altre qualità che non gli si possono negare. E, comunque, Bob Dylan i suoi rischi se li è presi e ne ha pagato le conseguenze. A prendere la sua bella razione di fischi e persino insulti Dylan aveva fatto l’abitudine già diversi anni prima della sua cosiddetta conversione, soprattutto quando si faceva accompagnare da The Band in una delle prime tournée negli stadi, dove la sua svolta elettrica non sembrava essere particolarmente gradita. E non tutti hanno le spalle sufficientemente larghe per farsene carico. Levon Helm, batterista e voce principale di The Band nonché unico musicista statunitense del quintetto, non resse la pressione e, stanco di essere subissato di fischi, abbandonò prematuramente. Ma Dylan le ossa forti se le era fatte ancor prima della svolta elettrica al festival di Newport – dove essersi presentato nelle veste di teddy boy insieme a una band di ruvido rock blues davanti ai beatnik fighetti della New York protestataria non era piaciuto per nulla – smettendo di suonare canzoni di protesta per passare a brani di introspezione, inizialmente mimetizzati da sfumature folk. “I don’t believe you, you’re a liar”, rispondeva dal palco di un teatro inglese a un fan che gli dava del Giuda, del traditore.
Se per quello, molti anni dopo, persino un rocker più “innocuo” (non perché meno intenso ma, semplicemente, perché investito quasi ufficialmente del titolo di ambasciatore del rock a stelle e strisce) come John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival si trovò alle prese con fan che mal digerivano le sue posizioni di aperta critica dell’interventismo militare americano nel Golfo Persico. E, a sua volta, se ne fregò. Quando Dylan iniziò a trasformare le sue esibizioni rock in spettacoli gospel, con tirate evangeliche e citazioni dirette di passi delle Scritture, diversi suoi fan si alzarono e, non senza aver espresso sonoramente la propria insoddisfazione, abbandonarono la sala. Eppure, il Dylan di quel periodo è musicalmente uno dei più interessanti e intensi della sua lunga carriera. Quasi mai lo si è sentito vocalmente più in palla, con un cantato a tratti grintoso e a tratti delicatissimo. Il sound della band è particolarmente convincente, una sapiente miscela di gospel classico, soul di Muscle Shoals (località dell’Alabama dove negli anni Settanta vennero incisi tantissimi dischi di grande spessore) e rock’n’roll grezzo. E, in fondo, sarà pur vero che chi acquista un biglietto vuole assistere a uno spettacolo di un certo livello, ma aspettarsi da Bob Dylan qualcosa di preconfezionato è un po’ come avventurarsi sulle coste irlandesi in una giornata di sole senza portarsi appresso un ombrello. Anche il modo compiaciuto con cui Dylan presenta la sua band, apostoli più che compagni musicisti, ha un che di molto intenso.
I tre capitoli (anzi quattro). Eppure, malgrado tutto, ancor oggi sono in tanti a storcere il naso di fronte ai tre dischi “cristiani”. In realtà, più di una trilogia, si tratta di quattro dischi, perché lo stesso Infidels è figlio del periodo cosiddetto cristiano. Ed è un buon disco. E, in fondo, a Dylan interessavano più il messaggio e l’entusiasmo che creava in lui in un momento difficile che non l’adesione cieca al movimento dei “born again Christians”, i cristiani rinati, quelli che pensavano che ci fosse bisogno di un secondo battesimo consapevole, quelli messi alla berlina da un altro grande cantautore americano, quel Randy Newman che addirittura intitolò un suo LP Born again. “Ci sono tante persone che vivono la vita del vero cristiano, con parole e fatti, ma che non si considerano credenti” ammonisce Dylan. “E ce ne sono altrettante che si professano cristiani e le cui azioni e parole dimostrano che non saprebbero distinguere Cristo da un buco nel muro.” Sempre sul pezzo, il nostro premio Nobel.
Il suo “Never Ending Tour” non è effettivamente ancora finito e non finirà. Fra un impegno e l’altro, Bob trova pure il tempo di creare cancellate di ferro, saldandole lui stesso – ho scoperto che, incredibilmente, saldare può essere un’attività creativa, oltre che un potente antistress – ora che pare meno interessato ai cancelli dell’Eden. A ben pensarci, le immagini di distruzione biblica sono da sempre presenti nella sua variegata poetica. Bob Dylan ha sempre fatto man bassa di tutto ciò su cui abbia posato gli occhi. Non è chiaro se la scelta di fare riferimento quasi diretto, addirittura letterale, a determinati passi della Bibbia e del Vangelo sia una scelta di comodo, un ritorno dell’autore agli insegnamenti ebraici che inevitabilmente deve avere fatto suoi o, addirittura, una vera e propria ossessione per messaggi messianici che hanno una arcana forza travolgente. Ascoltatevi “When the ship comes in”, dal disco The times they are a-changin’ del 1974 – santo cielo, questa canzone Bob l’ha scritta a ventitré anni! – e, forse, capirete. E, se non capite, pazienza. Non l’ha capito nemmeno lo sposo che attende ancora all’altare (“The groom’s still waiting at the altar”).